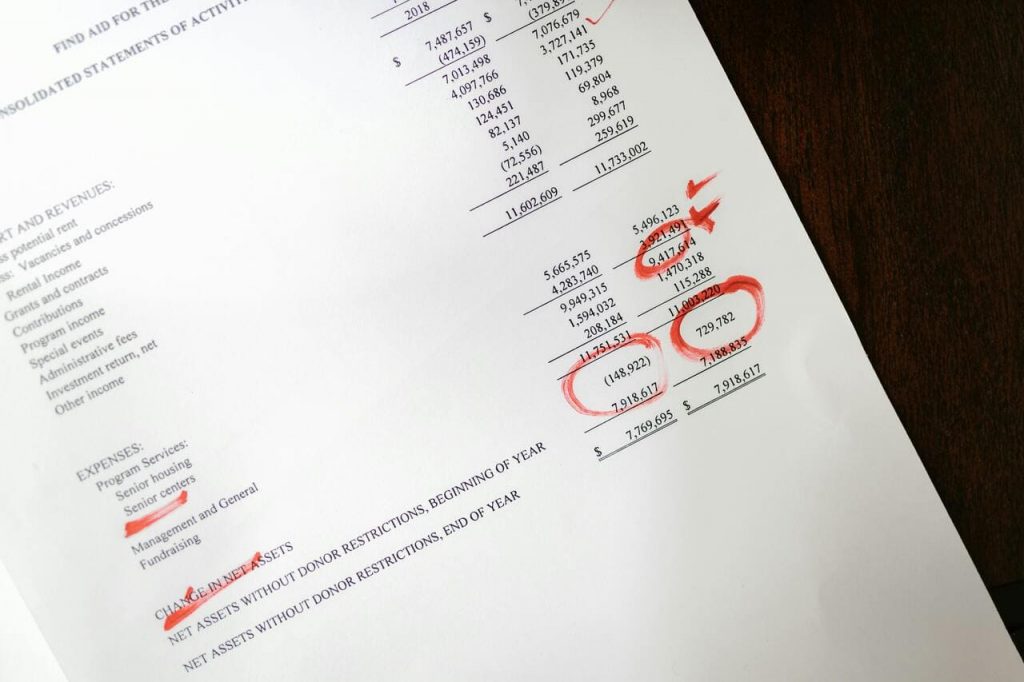A cura di Marco Cavaliere 1.0 La prevenzione della crisi nelle imprese sequestrate: obblighi organizzativi e segnalazioni La riforma della disciplina della crisi d’impresa, attuata mediante il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ha introdotto un complesso sistema normativo orientato all’emersione anticipata delle situazioni di difficoltà economico-finanziaria, nella prospettiva di una gestione tempestiva ed efficiente delle stesse da parte dell’imprenditore e degli organi a vario titolo coinvolti. In tale contesto, le disposizioni contenute negli artt. 25-octies, 25-novies e 25-decies CCII assumono una rilevanza sistemica, prevedendo un articolato meccanismo di segnalazioni e doveri attivatori, che dovrebbe trovare applicazione anche nell’ambito delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’art. 3 CCII, infatti, prevede, per l’imprenditore individuale, l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie per fronteggiarlo; per l’imprenditore collettivo, invece, il medesimo articolo impone l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’art. 2086 c.c., che consenta di cogliere in tempo utile i segnali premonitori della crisi e di porvi rimedio. L’art. 375 CCII ha inciso profondamente su tale disposizione civilistica, introducendo un secondo comma all’art. 2086 c.c., che impone all’imprenditore in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale e di attivarsi per l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi. Conseguentemente, l’art. 377 CCII ha apportato numerose modifiche al codice civile, tra cui spicca l’intervento di cui all’art. 379 CCII, che ha sostituito i commi terzo e quarto dell’art. 2477 c.c., introducendo nuovi criteri quantitativi per l’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative. In virtù di tali modifiche, le società tenute alla nomina dovranno procedervi entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, ove superino per due esercizi consecutivi le soglie fissate dalla norma. Il sistema di emersione anticipata della crisi si articola, dunque, su un doppio livello: da un lato, obblighi di monitoraggio in capo all’imprenditore, e dall’altro, doveri di segnalazione e attivazione posti a carico dell’organo di controllo. Quanto al primo profilo, l’imprenditore è tenuto sia a predisporre ex ante un adeguato assetto organizzativo, sia a effettuare un costante monitoraggio della situazione economico-finanziaria della società. Con riferimento agli organi di controllo, l’art. 25-octies CCII impone l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi. La segnalazione da parte dei cd. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione), disciplinata dall’art. 25-novies CCII, è vincolata alla presenza di specifici crediti rilevanti, come dettagliatamente indicato nel primo comma, lett. a), b), c) e d); i termini e le modalità sono regolati dai commi successivi. Ai sensi dell’art. 25-decies CCII, le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, in caso di revoca, variazione o revisione di affidamenti, sono tenuti a darne comunicazione anche agli organi di controllo societari, se esistenti. Nessuna previsione è tuttavia espressamente dedicata alle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria, neppure a quelle rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 104 disp. att. c.p.p., pur essendo, a parere di chi scrive, tali imprese soggette ai medesimi obblighi. 2.0 Il ruolo dell’amministratore giudiziario nella rilevazione tempestiva della crisi Da un punto di vista operativo, ci si interroga su chi, una volta nominato l’amministratore giudiziario, sia il soggetto legittimato a istituire l’assetto organizzativo richiesto dall’art. 2086 c.c., ovvero a recepire e attuare le segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o dai creditori pubblici qualificati. Ulteriore questione riguarda l’individuazione del soggetto abilitato a richiedere la nomina degli organi di controllo o del revisore, ai sensi dell’art. 2477, commi terzo e quarto, c.c. Tali interrogativi non appaiono affatto oziosi, poiché il d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) non prevede un automatico subentro dell’amministratore giudiziario nella carica di amministratore civilistico della società. L’art. 41, comma 1-ter, CAM, dispone che, in caso di sequestro di partecipazioni sociali idonee a determinare le maggioranze ex art. 2359 c.c., il tribunale può impartire direttive circa la revoca degli amministratori in carica, nominando – ai sensi del comma sesto – l’amministratore giudiziario quale nuovo amministratore della società. In assenza di tale nomina, il tribunale deve comunque disciplinare le modalità di controllo da parte dell’amministratore giudiziario. Pertanto, nei casi in cui venga disposta la revoca dell’amministratore in carica e la contestuale nomina dell’amministratore giudiziario quale legale rappresentante della società, sarà quest’ultimo, previo nulla osta del giudice delegato, a provvedere: (i) all’istituzione degli assetti organizzativi di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c.; (ii) all’adozione delle misure conseguenti alla segnalazione ricevuta ai sensi degli artt. 25-octies e 25-novies CCII; (iii) all’eventuale adeguamento dell’atto costitutivo e alla nomina degli organi di controllo ai sensi dell’art. 2477 c.c. L’autorizzazione giudiziale è imprescindibile e dovrà essere richiesta al giudice delle misure di prevenzione o, in ambito penale, al giudice per le indagini preliminari. In caso contrario, l’amministratore giudiziario potrebbe incorrere in responsabilità civile per colpa grave o dolo, in responsabilità amministrativa (ad es. per omessa convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2631 c.c.), nonché, in ipotesi di gravi irregolarità, nella revoca dell’incarico ad opera del tribunale. Più problematica è l’ipotesi in cui il tribunale non abbia disposto né la revoca dell’amministratore civile né la nomina dell’amministratore giudiziario quale legale rappresentante, né abbia stabilito modalità concrete di controllo. In tale evenienza, la posizione dell’amministratore giudiziario risulta ambigua, non potendo questi agire iure proprio in sostituzione dell’organo amministrativo, né essendo titolare ex lege dei poteri gestori. In giurisprudenza è stato affermato che il sequestro di azienda e partecipazioni non comporta ex se la trasformazione dell’amministratore giudiziario in amministratore civilistico; occorre, a tal fine, una delibera assembleare o un provvedimento espresso del tribunale. Una soluzione praticabile è che l’amministratore giudiziario, nei casi in cui l’amministratore in carica coincida con la figura dell’imprenditore (come nelle imprese a connotazione familiare), formuli richiami e solleciti formali, invitandolo ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3